
Una veduta di alcune delle architetture fantastiche della Scarzuola, la “città-teatro” progettata dall’architetto Tomaso Buzzi nel cuore dell’Umbria (Montegabbione, Terni)
Un paesaggio dantesco. Un eremo singolare. Uno dei primi conventi francescani. Il Poverello in levitazione. Il sepolcro di Todeschina, figlia del Gattamelata, celebre capitano di ventura. Un “occhio alato”, esplicito omaggio a Leon Battista Alberti. La misteriosa Torre del Tempo, ispirata alla sequenza di Fibonacci. Il labirinto che richiama la cattedrale di Chartres. I “mostri” e le visioni di Bosch. E un libro, bellissimo e misterioso, come guida: la “Hypnerotomachia Poliphili”, scritto da Francesco Colonna, frate libertino del Quattrocento.
I medievalismi si intrecciano con i rimandi alla classicità, le tracce del Rinascimento e le sperimentazioni novecentesche, nel “folle volo” surrealista della Scarzuola, un luogo affascinante, nascosto tra i boschi dell’Umbria. Un giardino ermetico che diventa un sogno, dentro il quale è possibile passeggiare, come fuori dal tempo, lungo il percorso iniziatico voluto da Tomaso Buzzi, uno dei più grandi e geniali architetti del XIX secolo.
Passeggiare dentro un sogno. È possibile in Umbria. Lontani dallo spazio e dal tempo. All’interno di un giardino, ascoltando il lieve rumore del vento, si può rimanere intrappolati in una dolce prigione onirica.
Il pensiero corre alla mappa consultata poco prima. E e al nome del comune che indica il curioso destino del viaggio: non a caso, Montegabbione. Qui, vicino al paesino di Montegiove, non sono solo gli occhi a guidare la scoperta dei luoghi: bisogna affidarsi all’anima che respira e, passo dopo passo, in un labirinto di emozioni, ritrova pensieri tenuti a lungo segregati.
La Scarzuola è una visione. Per afferrarla bisogna seguire la traccia sinuosa di una strada sterrata. La linea bianca disegna saliscendi nel verde intenso del bosco. Poi, una lieve salita annuncia un convento, protetto da un muro di pietra. La campanella che segnala il viandante precede l’apertura di una porta su un nuovo mondo, a due passi da casa.

Il giardino del convento francescano da cui si accede alla Scarzuola
Oltre il muro di cinta, un prato e una chiesa accolgono i visitatori e nascondono alla vista le architetture della città teatro
Ma dove siamo? C’è una chiesa e un quieto giardino, raccolto dai cipressi e costeggiato da edicole sacre. Lo sguardo è invaso da un senso di pace, da una serenità improvvisa. L’oasi di silenzio precede altre scoperte. E dopo l’oratorio svela una pietrificata e affascinante foresta di simboli. All’improvviso appare una città ideale, concepita come una stupefacente macchina teatrale. Tra statue, citazioni e rimandi alla classicità, emergono misteriose scenografie.
Un intrico di segni d’arte. Sette teatri in successione. E poi, in alto, l’acropoli: una collinetta di edifici affastellati che racchiude, in scala ridotta e proporzioni diverse, il Partenone, il Colosseo, il Pantheon, l’Arco di Trionfo, la Piramide, la Torre Campanaria e il Tempio di Vesta. Il misterioso e fragile labirinto di tufo sembra un libro di architettura fantastica a cielo aperto. Un compendio di arte dei giardini. Una sfavillante antologia manierista tra mostri di pietra, monogrammi, motti, bandiere, statue zoomorfe, specchi d’acqua, scale, scalette e colonnati.
Non c’è un progetto, una mappa da seguire, un’unica via con un ingresso o una uscita esclusiva. Tra le scene di pietra sembra che il tempo sia sospeso. E il cammino diventa un percorso iniziatico. Siamo su un palco o forse in un museo. Immersi in un sogno ermetico, in un luogo “non finito”, dove l’infinito si insegue, comunque.
E vaghiamo, trascinati dal “folle volo” surrealista dell’uomo che ha pensato tutto questo. Perché la Scarzuola, più di ogni altra cosa, è l’autobiografia in pietra del suo autore: Tomaso Buzzi, architetto dei principi e principe degli architetti.
Tomaso Buzzi, nato a Sondrio nel 1900, si è spento a Rapallo nel 1981

Tomaso Buzzi, nato a Sondrio nel 1900, si è spento a Rapallo nel 1981
UN ARISTOCRATICO DEL GUSTO Per capire questo spicchio d’Umbria segreta bisogna quindi, prima di tutto, provare a decifrare il mistero di un uomo straordinario. In senso letterale: fuori dagli schemi. Ossessionato dai cataloghi ma certo non catalogabile. Un anarchico liberale. Un gran borghese con l’istinto del ribelle. Urbanista, architetto e designer. Collezionista raffinato. Ma anche filosofo, poeta, scienziato, mago e bibliofilo. Un mondano che però sognava la solitudine. Attento al “bon ton” ma nemico dei conformismi. Geniale e contraddittorio. Quasi dimenticato dai suoi colleghi, forse è stato il più grande architetto italiano del Novecento. Sono rare le sue foto e si parla ancora poco di lui. Fra i suoi tanti capolavori, La Scarzuola è la sua opera più intima e più grande: Tomaso vi dedicò gli ultimi 24 anni di una vita ricca e tumultuosa, votata a una continua ricerca estetica. Perché Buzzi fu soprattutto un aristocratico del gusto. E la bellezza rimase il vero e unico metro di giudizio di tutte le sue azioni.
La sua data di nascita e quella di morte (1900-1981) ci ricordano che ha attraversato quasi tutto il “secolo breve” con la leggerezza e l’eleganza del predestinato, spesso da incompreso. Il suo mondo, colpito più dalle bizzarrie che dalle sue tante, formidabili intuizioni, lo stimava ma non lo capiva. E sovente lo relegò nel facile ritratto dell’artista “mattoide”: un dandy inafferrabile, un incontentabile snob.
Nacque a Sondrio da una famiglia benestante. A soli 23 anni era già laureato, con il massimo dei voti, in Ingegneria e Architettura. Fu subito protagonista della vivace vita culturale della Milano degli Anni Venti: fondò il Club degli urbanisti, partecipò a un famoso concorso per ridisegnare la città e organizzò manifestazioni d’arte di grande successo. Nel 1927 creò la società di arredamento Il Labirinto. Tra il 1932 e il 1934 fu direttore artistico della celebre e storica vetreria d’arte Venini di Murano. Con Gio Ponti, architetto di fama, saggista e designer, iniziò una collaborazione strettissima che lo portò a scrivere sulle pagine di Domus, la prima e più prestigiosa tra le riviste italiane di architettura. A meno di 30 anni era già famoso. Ricercato come architetto di giardini, inventore e restauratore.
Una copertina del maggio 1930 di Domus, la prima rivista italiana di architettura
Ma la sua visione post moderna dell’architettura, in cui gli stili e le tecniche si contaminavano di continuo, era troppo lontana dal razionalismo degli architetti alla moda negli anni del fascismo. Così fu emarginato. O meglio, si emarginò, disgustato dalla pochezza morale della classe dirigente, dall’affarismo dei colleghi e dalla corruzione dilagante. Scelse di dedicare le sue energie alla committenza privata, nell’illusione di essere più libero di esprimere la sua personale visione dell’architettura. A metà degli Anni Trenta si sgretolò anche il sodalizio umano e professionale con Ponti, a cui Buzzi non perdonò mai la vicinanza con gli ideali mussoliniani.
Così, da allora, fino agli Anni Cinquanta e per tutto il resto della sua vita, Tomaso diventò il coltissimo architetto di un mondo chic e danaroso di cui seguì gli spostamenti e per il quale progettò, tra feste vorticose, prime teatrali e lussuosi vernissage, ville, palazzi, piscine e appartamenti di pregio, tra Cortina, Forte dei Marmi, Saint Moritz, Cap d’Antibes, Firenze e il lago di Como. Negli anni del “boom economico” e della “dolce vita” fu l’ideatore delle famose “Terrazze Martini”, consacrate al rito dell’aperitivo, il segno distintivo del successo sociale di nuovi e vecchi ricchi e della “compagnia di giro” delle antiche famiglie dell’aristocrazia.
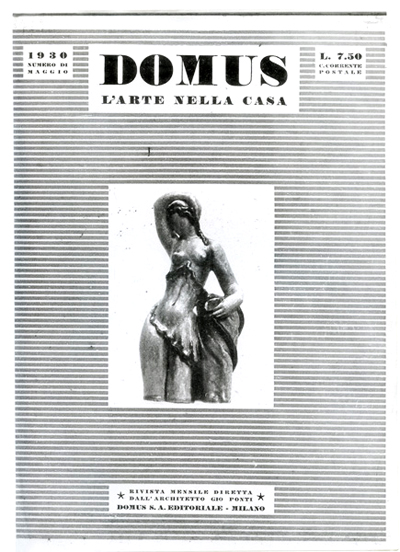
Una copertina del maggio 1930 di Domus, la prima rivista italiana di architettura
UNA VITA SEGRETA Nel volgere di poche stagioni, Buzzi è l’architetto più ricercato e più ricco d’Italia. Arreda la residenza degli Agnelli a Villar Perosa e quelle dei Pirelli, dei Marzotto e di altri industriali protagonisti del “boom” economico. E’ conteso da un gran numero di politici, ecclesiastici e intellettuali. Snobba i suoi colleghi che considera provinciali e accademici e affida le sue riflessioni sull’architettura solo a Vogue e Harper’s Bazaar. Insegna con entusiasmo “Disegno dal vero” al Politecnico di Milano. Cita Delacroix e ripete con lui: “Il disegno è la mia preghiera quotidiana”. Il suo furore creativo, unito alla incredibile tecnica a mano libera, si applica ai materiali più svariati: dalle tovaglie ai pizzi, dai merletti alle cornici, dagli orologi da tavolo ai giardini. Si occupa anche degli arredi delle navi di lusso e degli allestimenti delle triennali d’arte. Vive al centro di un mondo dorato e pettegolo che percorre in lungo e in largo, in un carosello di appuntamenti mondani. Tanto frenetici da rendere inutile anche la costruzione di una cucina nel progetto della sua lussuosa casa romana. Buzzi dispensa la bellezza delle sue creazioni su una umanità privilegiata, toccata dallo sfarzo ma spesso lontana dal gusto. E riversa nei cocktail la pungente cattiveria di battute velenose. Come quella riservata ad una annoiata contessa capitolina, stupita del suo successo di architetto e che forse voleva solo fargli un complimento. La nobildonna commentò: “A Roma ormai c’è una malattia nuova, chiamata buzzite…”. Tomaso rispose con ironica perfidia: “Non aver paura. Non è contagiosa: i cretini ne sono immuni”.
L’ambasciatore Giulio Del Balzo, colpito dalla sua vitalità, descrisse in poche righe il fascino del personaggio: “Si innamorava di tutto, dagli alberi alle pietre, dagli insetti, ai libri, alle cattedrali…”.
Buzzi inizia a viaggiare, in tutti i continenti. Restaura e progetta alcune tra le più belle ambasciate italiane nel mondo. E’ divorato dalla curiosità della conoscenza. Ma insieme alla fama e al successo, cresce la sua inquietudine e la voglia di isolamento. La stessa che trascrisse, anni dopo, in un appunto: “Pur vivendo in mezzo alla gente del bel mondo quasi come uno di loro, e lavorando per i committenti in modo serio e professionale, in realtà io vivo una vita di sogno, segreta; in mezzo alle mie carte, i miei disegni, le mie pitture e le mie sculture”.
Nell’autunno del 1956, durante un viaggio in Messico, nei pressi di Acapulco, vide un piccolo e grazioso convento. E confessò ad alta voce ai suoi compagni di escursione la voglia di ritirarsi in un posto così, lontano dal mondo. Il marchese Paolo Misciatelli, proprietario del castello umbro di Montegiove, gli parlò allora della piccola chiesa della Scarzuola, sepolta nel verde della campagna umbra e che era in cerca di un compratore.
A Tomaso, come sempre, bastò uno sguardo per capire. E nel gennaio del 1957 perfezionò l’atto notarile con il quale diventò il proprietario della casa che racchiuse per sempre la sua anima.

San Francesco usa la scarza per costruire un riparo (affresco nel convento della Scarzuola)
PAESAGGIO DANTESCO La Scarzuola si chiama così per via della scarza, la frasca di una pianta acquatica che cresce nella zona e che ancora oggi è usata dai contadini per rattoppare le sedie. Proprio lì, in un imprecisato periodo dell’anno 1218, Francesco d’Assisi che tornava da uno dei suoi frequenti viaggi a la Verna, costruì con le proprie mani il suo umile giaciglio di scarza, vicino ad alcune grotte. Le sue preghiere fecero scaturire anche una fonte miracolosa. Francesco piantò allora anche un lauro e delle rose, simboli di sacralità e bellezza. E si fermò per alcuni giorni in quel luogo solitario, che emanava un’aurea mistica. Alcuni frati che seguivano il santo ne fecero il loro eremo. Fra di loro c’era anche Senso, un religioso perugino che visse alla Scarzuola per lunghi anni, rallegrato dal dono dell’estasi e delle lacrime e che proprio lì finì i suoi giorni, nell’anno di grazia 1270.
Molto tempo dopo il passaggio di Francesco, nel 1282, Nerio di Bulgaruccio dei Conti di Marsciano, proprietario di quelle terre, fece costruire una chiesa dedicata alla Santissima Annunziata e un piccolo oratorio che affidò alle cure dei frati minori. Lui stesso, dopo la morte della moglie, indossò il saio del penitente. Poi i suoi figli edificarono il convento che divenne anche il sepolcro della nobile famiglia. Così i frati, con la forza delle loro preghiere, diventarono i pii guardiani delle tombe dei conti. Sotto il pavimento della chiesa furono sepolti lo stesso Nerio e molti dei suoi discendenti, fra i quali c’era pure Todeschina, figlia minore del capitano di ventura Gattamelata di Narni, che aveva sposato uno dei nobili marscianesi. Una iscrizione, ancora oggi, avverte che sarà maledetto per sempre chi violerà la pace eterna della cripta.
Già agli inizi del Trecento, per ammissione degli stessi francescani, la Scarzuola era “il convento più eccentrico della provincia serafica”. Padre Benvenuto Bazzocchini, nella sua Cronaca, la descrive così: “Nessuna strada carrozzabile, nessun paese nelle vicinanze: in alto un po’ di cielo e intorno il murmure dei venti e delle foreste”.

Gli appunti di Tomaso Buzzi, che Marco Solari porta con sé quando guida i turisti alla Scarzuola
Un paesaggio dantesco. Una selva oscura nella quale Buzzi si ritrovò ben oltre la metà del cammino della sua vita.
Oggi, a guidare i visitatori e traghettarli con maestria nel mondo segreto del geniale architetto, c’è un Caronte originale, sfuggente e provocatorio: Marco Solari, l’erede di Tomaso. Accoglie i turisti nascosto dietro un tratto nervoso e grandi occhiali scuri. Armato dei disegni originali di Buzzi, che ora sventola in alto come una bandiera e ora nasconde dietro la schiena, irride e stupisce di continuo l’uditorio, con frasi lapidarie, improvvisi silenzi e domande che rimangono sospese in aria, come l’eco del riso buffo e insieme inquietante che le accompagna.
Dietro alle sue parole, lungo le strade di questo labirinto, che Buzzi definiva “regno di fantasia pietrificata”, torna alla mente un dimenticato slogan del Sessantotto: “Una risata vi seppellirà”. Perché, comunque vada, da qui si esce pensierosi, appagati, euforici o forse perplessi. Ma non indifferenti. E di certo diversi da come si è entrati.
Marco Solari ereditò questo singolare eremo nel 1982. Quando arrivò per la prima volta, vide la città sacra e quella profana assediate dall’erba, semisepolte dalla natura rigogliosa dei luoghi. Da allora, come un archeologo, ha scavato per anni, con pazienza nell’enorme mole di appunti che Tomaso aveva conservato nel suo rifugio segreto. E ha preservato e completato i progetti di Buzzi con un lavoro fedele e rigoroso che ha impegnato per tre decenni le sue energie. Così la cittadella surrealista è riemersa.
Buzzi pensava alla sua creazione come a “una piccola Pompei di un solo uomo e uomo solo. Una carcassa, un guscio vuoto, una conchiglia fossile, uno scheletro, un grido impietrato”. Adesso, grazie a Solari, prigioniero come gli incuriositi turisti di un giorno del sogno di Tomaso, la Scarzuola parla ancora. Ma per capire bisogna saper ascoltare. E affrontare il viaggio della scoperta liberi dai pregiudizi.

San Francesco in levitazione (foto: umbriatakeaway.com)
SAN FRANCESCO IN LEVITAZIONE Le sorprese cominciano appena si varca la porta della chiesa. Le pareti di una cappella secentesca mostrano 14 santi con le teste squarciate dalle accette e i colli e le guance infilzati da spade e pugnali: gli sguardi comunque serafici dei francescani splatters sembrano incrociare quello pensieroso della vicina statuetta di una madonna agghindata come una bambola antica.
Poco lontano, colpisce l’intarsio raffinato di un ciborio in legno finemente lavorato e l’eleganza e la varietà di altre reliquie sulle quali domina una grande lampada argentata appesa al soffitto.
Ma lo stupore arriva davanti a un affresco di autore ignoto che risale al 1240: raffigura Francesco in levitazione, ovvero nell’atto estatico di sollevarsi da terra, mentre contempla, colmo d’amore, il Cristo crocifisso. E’ una delle prime immagini conosciute del santo di Assisi. Un’opera straordinaria, a lungo coperta da un intonaco, sbucata fuori a metà degli Anni Novanta, quasi per caso, quando Marco Solari fece smantellare una struttura incassata dietro il coro. Il dipinto segue in modo fedele il racconto riportato da Tommaso da Celano nella “Vita prima”, la più antica biografia del Poverello: i piedi di Francesco si staccano da terra e il santo cade in trance mentre sul suo corpo si formano le stimmate, chiodi sanguinanti della Passione.
Quasi nascosto, sulla sommità dell’abside, emerge il segno del Tau, l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico, il simbolo di un percorso di redenzione che tanta rilevanza occupò nella vita e nei gesti di San Francesco.
C’è appena il tempo di riprendersi quando, appena fuori il convento, l’attenzione è attratta dall’anta di una porta della cella di un frate su cui è intagliata la sorprendente immagine di un San Francesco nudo, con una coppa di vino in mano, nell’atto gioioso di un brindisi. E’ la prima immagine conosciuta del santo come “giullare di dio”. Una caricatura goliardica incisa da un fraticello ignoto. Stupisce che sia sfuggita alla censura dei superiori del religioso, soprattutto se si osserva la data dell’opera, impressa proprio sotto l’immagine oscena: 1738, ben prima dell’epoca dei Lumi e della furia anticlericale delle truppe napoleoniche. La porta, rimossa dalla cella del frate, per molti anni fu adibita addirittura come chiusura della porcilaia del convento. Forse, più che un graffito blasfemo, è la traccia di una lontana eresia edonista, che per secoli sconvolse l’ordine francescano: quella dei cosiddetti “fraticelli”, i seguaci di Bentivenga da Gubbio che nei primi anni del Trecento predicava che poiché Dio è amore in tutte le sue forme, l’Inferno e il peccato non esistono e che quindi anche i frati potevano abbandonarsi liberamente ai piaceri della carne.
La Chiesa condannò quei francescani eretici al carcere e alla morte già nel 1318. Ma la pianta dell’eresia non fu estirpata del tutto: sopravvisse a lungo nelle campagne insieme a credenze pagane e antiche superstizioni.
Nel mazzo delle carte della vita che abbiamo a disposizione, anche Buzzi si sentiva un giullare, fuori dalle maschere archetipe che ci vestono ogni giorno. Come l’arcano del “Matto” del gioco dei tarocchi, voleva rappresentare la sua esistenza fuori dalle sbarre dello spazio e del tempo. Non avere un numero assegnato né un doppio. E muoversi oltre la rigidità degli schemi. Al modo dell’uomo dei campanelli, voleva avere la possibilità di colorare e musicare a piacimento il mondo intorno a sé. Forse anche per questo alla Scarzuola non c’era un impianto elettrico e nemmeno il telefono e il riscaldamento.

La scultura dell’Occhio alato, omaggio a Leon Battista Alberti, introduce alla città profana
L’OCCHIO ALATO E LA LIBELLULA Fuori dalla parte sacra, il giardino simbolico è annunciato da un segnale rivelatore: “un occhio alato”. La scultura buzziana è un omaggio a Leon Battista Alberti, il grande architetto ed umanista rinascimentale, richiamato in una celebre medaglia in bronzo di Matteo dei Pasti. Ma è anche una autocitazione: “L’Occhio” era il soprannome che le due sorelle di Buzzi avevano dato a Tomaso, che fin da piccolo, osservava e disegnava a velocità prodigiosa tutto quello che vedeva. Conservò l’abitudine pure da adulto: in viaggio, sui treni e le navi, portava sempre con sè un taccuino da pittore per stendere sulla carta bianca le immagini che lo colpivano. Gae Aulenti, che fu sua allieva al Politecnico di Milano, raccontava lo stupore degli studenti di fronte al professore sciamano, capace di tracciare segni pure con la matita infilata nell’ombelico.
Buzzi disegnava anche durante i concerti alla Scala, nel buio della sala, per fermare in immagini la musica, “misteriosa forma del tempo” dell’amato Jorge Luis Borges.
E proprio dall’Occhio Alato, in pochi passi, si arriva alla Fontana del Tempo, costruita accanto alla sorgente di San Francesco e all’antica pescheria che i frati usavano per allevare le trote. E’ un orto minuscolo e segreto, preludio del racconto architettonico che attende il viaggiatore. La scarza cresce sulle pareti e all’interno della bella fontana, sulla quale campeggia una clessidra, antica misura dei giorni e delle notti, insieme alla vezzosa scultura di un leone, simbolo della forza che occorre per affrontare le prove che ci riserva la vita.
Nell’acqua, l’elemento alchemico che trattiene la memoria, confuse tra melma e le foglie bagnate, vivono le libellule. Non sembra un caso che abitino l’umida stazione di partenza del percorso iniziatico: la libellula striscia nella fanghiglia ma poi esce dall’involucro al quale sembrava condannata per sempre e arriva a volare lungo i sentieri ombrosi e le volte dei rampicanti.
Nel giardino pensato da Tomaso Buzzi, al limitare di tre sentieri, il viaggiatore deve scegliere la strada da seguire di fronte all’enigma di tre porte di verzura topiata.
In quella di sinistra, Gloria Dei, il percorso riporta all’indietro, al convento appena lasciato, alla rinuncia della vita contemplativa.
Quella di destra ha nome Gloria Mundi. Ma è il vicolo cieco dei condizionamenti che subisce ogni individuo: la strada della fama, della vanità e dell’accumulo delle ricchezze materiali offusca la mente e non porta da nessuna parte. Così, si è costretti a tornare sui propri passi.
La terza porta, sormontata dalla scritta Mater Amoris, è cinta ai lati da due 8 scolpiti nel ferro battuto: sono i numeri dell’infinito. Segnalano il corridoio di un giardino rinascimentale, una casa senza tetto e dalle pareti verdi. E’ il labirinto dal quale si deve cercare di uscire per provare a conoscere se stessi. Un limite tra la città sacra e un’altra, ideale e profana, segreta e interiore, dove grazie alla conoscenza e all’esperienza possiamo liberarci da ogni schiavitù. E capire che possiamo essere artefici del nostro destino.

Una pagina dell’Hypnerotomachia Poliphili, guida per il viaggio alla Scarzuola
UN LIBRO MISTERIOSO La guida di questo viaggio parte dalla lettura di un libro misterioso che Tomaso Buzzi sfogliò da ragazzo e dal quale rimase affascinato per tutta la vita: l’Hypnerotomachia Poliphili, scritto da Francesco Colonna, un frate libertino di Treviso vissuto nella seconda metà del Quattrocento. Il “combattimento d’amore in sogno di Polifilo” racconta il cammino verso la segreta verità del mondo di Polifilo che in sogno ritrova l’amata ninfa Polia superando ostacoli di ogni sorta, tra prodigi e trabocchetti. Il tema del percorso è l’Amore, capace di vincere anche la morte.
L’Hypnerotomachia Poliphili è anche il primo volume stampato con le immagini: 196 meravigliose xilografie, la maggior parte delle quali viene attribuita ad Andrea Mantegna. E’ considerato il libro più bello che sia mai stato pubblicato. Fu editato nel 1499 nella celeberrima tipografia veneziana di Manuzio. E cinquecento anni dopo la sua prima uscita conserva il fascino oscuro del motto più famoso del suo autore, le parole magiche della conoscenza iniziatica: “Festina lente”, ovvero “Affrettati lentamente”.
Ancora oggi, rimane il testo più arduo della letteratura italiana: il periodare boccacesco è infarcito di citazioni dotte, latinismi e enigmatiche espressioni. Condite da erbari, bestiari e stravaganze assortite. Una favola antica e al tempo stesso modernissima il cui linguaggio complicato e affabulatorio fa pensare, in modo sorprendente, ai romanzi maturi di James Joyce.
Un viaggio allegorico dell’anima, alla ricerca della vera sapienza, tra incubi e meraviglie: “La battaglia d’amore in sogno di Polifilo, dove si mostra che tutte le cose umane altro non sono che sogno e dove, nel contempo, si ricordano molte cose, degne in verità di essere conosciute”. Colonna descrive una città ideale nella quale si susseguono templi in rovina, fontane, obelischi, piramidi, iscrizioni, lapidari e deliziosi e lussureggianti giardini.
Così, dalla porta Mater Amoris, si imbocca un tunnel di foglie e si arriva a un vascello di pietra posto al centro di una vasca d’acqua e pronto a salpare alla ricerca della ninfa amata. Nel corso del viaggio Polifilo dovrà affrontare e domare anche i mostri dell’inconscio per arrivare infine a Citera, l’isola di Venere, la dea della Bellezza.
Il tufo, cenere vulcanica pietrificata e destinato a tornare polvere, interpreta alla perfezione il senso di caducità che Buzzi voleva imprimere alle sue architetture

Il tufo, cenere vulcanica pietrificata e destinato a tornare polvere, interpreta alla perfezione il senso di caducità che Buzzi voleva imprimere alle sue architetture
ARCHETIPI E ROVINE Il libro è una delle chiavi per aprire i misteri della Scarzuola. Ma non è l’unica. Buzzi era un appassionato sostenitore del ruinismo, una corrente artistica secondo la quale le opere dovevano essere lasciate in balia del tempo, per essere poi plasmate liberamente dalla natura.
Per scelta, realizzò la sua città ideale con il tufo, un materiale friabile e poroso. Una pietra caduca, come la vita. Deperibile e sofferente di fronte alle gelate invernali e ai segni delle stagioni. Per questo della città edificata nel folto del bosco, non è stato lasciato un progetto definito. L’opera poteva così tornare cenere ed essere inghiottita dal paesaggio. Il “non finito” per Buzzi donava alle architetture la quarta dimensione, quella del tempo. Tomaso scriveva: “I palazzi cambiano proprietà, vengono modificati o distrutti, le collezioni disperse, dilapidate. Solo le rovine rimangono: come villa Adriana, villa d’Este, Bomarzo o le abbazie come San Galgano”.
Pure la Scarzuola appare, nella sua immaginazione, “La metamorfosi di un uomo in una rovina pietrosa”. Un sogno di architettura che diventa realtà. Ma nel mare dell’inconscio non navigano piani precisi e definitivi ma solo “gli schizzi e i ghiribizzi”. Così il sogno di Tomaso è quello di tutti quelli che vi passeggiano dentro. C’è spazio per l’inconscio personale nel quale viene conservato e si agita ciò che la coscienza vuole rimuovere o cancellare. Ma si esplora anche l’inconscio collettivo, composto dagli archetipi, gli schemi di comportamento istintivo di cui parlava Jung. Ereditari e identici per tutti noi, nei sogni, nelle mitologie e nelle tradizioni religiose. Propri dell’uomo. Come la nascita, la morte, le immagini paterna e materna, i rapporti fra i sessi.

Una visuale della scenografica acropoli
TRA MOSTRI E LABIRINTI Nel sogno della pietra che diventa poesia è possibile lasciare tutti gli involucri che ci avvolgono. Il tema della metamorfosi e del viaggio si legge camminando.
Al primo approdo, la città ideale si offre allo sguardo in tutta la sua luce dai palchi del Sole e della Luna. La visione è spettacolare. Perché la vita è un teatro, nel quale ciascuno recita una parte. La scenografia, come in una sognante rappresentazione, può cambiare, essere smontata e poi rinascere. Nella vita e nel sogno niente è come appare, tutto può essere di continuo reinventato, in un eterno presente.
Così Tomaso Buzzi, l’architetto dimenticato, ancora oggi getta sul verde prato del suo giardino i preziosi brandelli delle tante cose viste e conosciute nell’arco di una vita e poi le riassembla, insieme a noi, in un continuo gioco psicanalitico.
Davanti agli occhi scorrono le immagini delle architetture fantastiche con i mostri di Bomarzo, la Scala di Milano, il labirinto di Chartres, le fantasie di Arcimboldo, le visioni di Bosch…
Guardiamo il panorama vicino ad alcune vetrate che nell’ora del tramonto riflettono le architetture dell’acropoli. Sono gli specchi appesi ai muri porosi del teatro dell’Arnia, l’edificio che Tomaso volle nominare così per il “ronzare operoso delle api che si chiama buzzicare”. Un omaggio al lavorio incessante dei suoi pensieri, replicato in altri simboli in ferro battuto dorato disseminati tutto intorno. Piccoli gioielli, che spiccano ovunque tra le pietre: Api che indicano la laboriosità e il talento, Ali di Mercurio che raccontano l’intraprendenza e la tenacia e il Compasso, inno alla geometria e alla precisione matematica. Anche se lui non faceva molti calcoli, disdegnava la tecnologia e disegnava i suoi progetti a braccio. E quando costruiva spiegava a voce alle maestranze volumi e misure, quasi improvvisando.
Come nei sogni, alla Scarzuola le proporzioni non esistono. La città ideale è fatta a piani: in basso le rocce e il buio delle carceri piranesiane, tana delle forze oscure che imprigionano l’uomo nei suoi istinti bestiali. Poi i palazzi dei nobili e le case degli artigiani, i luoghi operosi del lavoro che redime l’uomo. In alto, le meraviglie dell’architettura e le piazze dell’anima.
Siamo in viaggio, dentro il nostro inconscio e in quello dell’autore. Incontriamo insieme Dalì e Magritte, Serlio, Vitruvio e Palladio. Luoghi diversi sono uniti nello stesso luogo. Al centro della visione vigila un grande e insonne occhio di tufo: dal foro della pupilla si scorge lo studiolo di Tomaso da cui l’artista, non visto, dominava la visione di tante meraviglie. Tutto intorno, la scienza e i capricci si mescolano con i fasti e le miserie della Storia. E nel labirinto anche i mostri della mente possono finalmente essere ammansiti.

Il grande orologio della Torre del Tempo, che incorpora la serie numerica di Fibonacci
LA NAVE DELLA MEMORIA Vista dall’alto, la Scarzuola è una una nave che ci trasporta nel tempo e nella memoria. Siamo a poppa: in senso antiorario seguiamo la scia dell’anima e scopriamo sette teatri in rapida successione: la Torre del Tempo, ispirata alla sequenza di Fibonacci con il grande orologio a forma di Uroboro. Poi la casa Capitello e la casa Stemma. E la Grande Madre, una gigantessa di pietra senza testa ma dai seni giganteschi: è la Madre Terra, polena della fantastica nave della Scarzuola, guardiana di due porte: quella della scienza e della tecnica e quella dell’arte e della fantasia. E’ Mater, la materia di cui siamo fatti e dalla quale ci siamo troppo allontanati: ha un cuore magmatico e ci chiede di infiammarci ancora per ritrovare noi stessi. Poco oltre, passiamo rapiti nel tempio di Apollo. E attraversiamo quello di Eros, fino a giungere al teatro del Corpo con l’effige dell’uomo universale impressa sul terreno.
Leggere la Scarzuola è un esercizio faticoso. Per Buzzi l’opera della sua vita doveva rimanere “misteriosa perché incomprensibile ai più” e poteva essere capita solo “da pochi infelici eletti”, capaci di affrontare un cammino di consapevolezza.

La Grande Madre erutta dal collo schizzi metallici di “lava”
Tomaso vagheggiava di rappresentare al tramonto nella sua surreale città “Il flauto magico” di Mozart, l’opera che sentiva più vicina allo spirito della sua creazione: un viaggio in musica “attraverso la notte, verso la luce”. Ma considerava l’abisso tra l’eroe Tamino, che affronta le insidie del buio per arrivare alla conoscenza e Papagheno che si accontenta di soddisfare i suoi bisogni primari, rinuncia allo sforzo e canta soddisfatto: “Io non voglio in fondo sapienza, io sono un uomo naturale, che di sonno, cibo e bere si accontenta, e se possibile catturare qualche bella donnetta”.
Il coraggio di vivere è soprattutto quello di rinascere. E presuppone la discesa agli inferi. Dopo il percorso dei teatri, al fondo di una discesa, un mostro di pietra attende il viaggiatore, che viene inghiottito dalla grande bocca di una balena con le fauci spalancate. Flutti tufacei simulano l’acqua nella metafora della morte e della resurrezione. Da Giona a Pinocchio, ogni rito iniziatico richiede un passaggio di sofferenza. E l’uomo, spesso chiamato a compiti più grandi di lui, deve essere capace di affrontare il dolore, forma della conoscenza.
Sputati nel mondo, fuori dal ventre della bestia, c’è il tempo di meditare dentro la Torre della colonna rotta. Siamo smembrati e confusi, soli davanti alla salita che ancora ci attende, catapultati senza preavviso sull’enigmatica scena di un quadro di Escher.
È il momento in cui l’Io recupera i suoi brandelli dispersi e prova ricucire se stesso. Attese, ansie, paure e desideri si sono già mescolate molte volte nel viaggio allegorico sulle soglie di tanti palazzi sconosciuti. Ma il percorso di ascesi continua: dalla morte alla vita, dal buio alla luce, dalla terra all’aria, dalla materia allo spirito.
Adesso si può affrontare la ripida Scala della Vita, fiancheggiata da alte e ordinate colonne. E man mano che si sale cambia la visuale e l’orizzonte sulle cose, che appaiono sempre più chiare e distinte, come i frontoni, le guglie, le cupole e i tetti dell’acropoli che scintilla sulla vicina collina. Alla fine della salita ci attende una porta con il motto della Gerusalemme celeste: ” Amor vincit omnia”. L’amore vince ogni cosa. La forza vitale che abbiamo dentro di noi “move il sole e le altre stelle”.

Il cipresso, colpito da un fulmine nel 1970, è il centro ideale della città di Buzzi
UN CIPRESSO FERITO A MORTE Il percorso iniziatico sembra finito. Ma è solo un’altra illusione: il filo del cammino si riavvolge su se stesso, come in una spirale. E il nuovo scenario che si apre davanti ai nostri occhi mostra il retro della città e anche del sogno: ad ogni affaccio c’è una vista diversa sul parco e sulla valle dolce nella quale passeggiamo.
Il rovescio degli edifici è anche quello dei significati. I sensi e i secoli si mescolano con gli elementi primari, in una fusione alchemica, come nel colpo d’occhio di Tomaso: si vede la terra nella platea del vasto teatro e l’acqua della fontana più in alto. E poi il fuoco, rappresentato da un mascherone, che da lassù si fa sberleffi del mondo. Fino all’aria, dove si libra un Pegaso alato fatto di ferro e di creta.
Polifilo siamo noi. Con il cuore più libero, salpiamo alla ricerca della saggezza, passando accanto al Tempietto di Flora e Pomona e al teatro dell’Acqua. A fianco della vasca per le battaglie navali, c’è l’organo arboreo con le canne rappresentate dai cipressi. Nell’alto e circolare Tempio di Apollo, ci accoglie un giardino zen al centro del quale è piantato l’Albero della Memoria, un cipresso che nel 1970 fu colpito dal fulmine.
Per Buzzi, una rivelazione. Scrisse in un suo appunto: “Penso che il cipresso ferito a morte, attraversato dalla cima alle radici dal fulmine è quanto di più vicino al cielo vi sia alla Scarzuola, perché ha avuto una folgorazione, un contatto diretto dal cielo alla terra, è la sola cosa che “sa di cielo”. Per questo lo voglio preservare ad ogni costo”.

Tra le trine di pietra della Torre di Babele è conservato il ricordo della luce ultraterrena
Dietro l’albero che svetta come una solitaria cattedrale, si scorge la linea esile e leggiadra di una Torre di Babele che quasi imprigiona un enorme cristallo, simbolo del bambino che siamo stati prima di saper parlare, ancora in grado di riflettere la luce divina, destinata ad essere poi offuscata dal peso degli anni e dalla trita ripetizione di vite senza guizzi, uguali e preordinate, asfissiate dai pesanti involucri di ogni esistenza quotidiana.
Quasi nel punto più alto della fantastica cittadella c’è la scala a chiocciola del Sapere che sale ancora. Buzzi l’aveva dotata di un sistema di fili metallici capaci di emettere le note sotto la pressione dei piedi di chi era capace di arrivare lassù per realizzare il comandamento dell’oracolo di Delfi: “Conosci te stesso”.

Il palcoscenico dell’acropoli, visto dall’alto dopo la risalita, apre nuovi panorami
QUEL MESSAGGIO NELLA BOTTIGLIA Quel suono si intona con l’armonia del mondo. Perché nell’acropoli il percorso ascetico finalmente è compiuto: dal buio delle carceri siamo giunti alla bellezza apollinea dei più grandi monumenti del passato, tra i perenni segni di pietra della civiltà occidentale. Sono archetipi, all’interno vuoti, che nascondono una infinità di scomparti. E come in un termitaio, rivelano al visitatore molteplici punti di vista sul mondo sottostante.
Buzzi scrisse che la sua opera era un “messaggio nella bottiglia affidato alle onde del tempo”. Un desiderio malinconico di un uomo grande, consapevole della sua solitudine. Il palcoscenico costruito sul tufo attende lo spettacolo delle nostre vite individuali dove siamo attori improvvisati in cerca di metamorfosi, musica e applausi. Sulla riva dei giorni di ciascuno di noi vengono edificati di continuo infiniti castelli di sabbia, fragili e intensi, come la Scarzuola. E si coltiva la speranza.
Del resto, nei sogni tutto è possibile. Come sapeva bene anche Sante de Sanctis, il padre della psicologia e della neuropsichiatria italiana, studioso dei misteri del sonno, citato più volte da Freud e Jung nei loro scritti. Era nato a Parrano, qualche chilometro più a sud del sogno ermetico di Tomaso Buzzi. Ma questa è un’altra storia.
Federico Fioravanti
Per le visite:
Località Montegiove , Montegabbione, Terni
Tel. 0763 837463
www.lascarzuola.com
